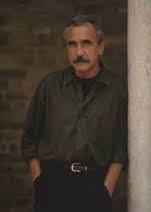 Ivano Ferrari è un poeta che evoca la rarità come valore: della qualità dei versi e della loro differenza, delle uscite editoriali, dell’attenzione che lui stesso dedica ai suoi testi (a volte dimenticati chissà dove e poi riemersi, anche dopo decenni). Per Einaudi esce nel 1999 “La franca sostanza del degrado”, un dono di “luce d’esilio a nebbie e pietre” (p. 176). Questo verso bellissimo sintetizza la frequentazione di una materia debordante, spinta ben oltre ogni margine, oltre l’orizzonte di attesa dei lettori anche più randagi. Il libro colpisce per la forza che annuncia, anche se mostra intermittenze di intensità, impigliata a volte in qualche approssimazione. Lì accade che la realtà si riduca a un temporaneo monologo laterale, incidentale, pur pretendendo definitività. Si rivela cioè il non finito, nonostante la perentorietà quasi sentenziosa specie dei componimenti più brevi, spesso appoggiati a un unico punto finale che chiude con durezza ogni discorso. Cosicché ogni sezione risulta attraversata da una tensione quasi elettrica, tra poli differenti di poesie più o meno riuscite. Tra le prime (p. 172):
Ivano Ferrari è un poeta che evoca la rarità come valore: della qualità dei versi e della loro differenza, delle uscite editoriali, dell’attenzione che lui stesso dedica ai suoi testi (a volte dimenticati chissà dove e poi riemersi, anche dopo decenni). Per Einaudi esce nel 1999 “La franca sostanza del degrado”, un dono di “luce d’esilio a nebbie e pietre” (p. 176). Questo verso bellissimo sintetizza la frequentazione di una materia debordante, spinta ben oltre ogni margine, oltre l’orizzonte di attesa dei lettori anche più randagi. Il libro colpisce per la forza che annuncia, anche se mostra intermittenze di intensità, impigliata a volte in qualche approssimazione. Lì accade che la realtà si riduca a un temporaneo monologo laterale, incidentale, pur pretendendo definitività. Si rivela cioè il non finito, nonostante la perentorietà quasi sentenziosa specie dei componimenti più brevi, spesso appoggiati a un unico punto finale che chiude con durezza ogni discorso. Cosicché ogni sezione risulta attraversata da una tensione quasi elettrica, tra poli differenti di poesie più o meno riuscite. Tra le prime (p. 172):
Oggi Dio è chiaro
parla semplicemente
e arriva con dolcezza
anche alle unghie
– c’è stato un volo, credo –
per addentare quell’osso di cielo
con reciproco azzurro.
E tra le seconde (p. 168):
Davanti a me
i tuoi occhi chiari
entrano nel naturale
mondo delle maschere.
La raccolta “Macello”, in parte anticipata nel 1995 nell’antologia “Nuovi poeti italiani 4”, esce sempre per Einaudi nel 2004. Lo scrittore Antonio Moresco, amico di Ferrari e autore di una bella recensione (uscita su “Pulp” e poi su “Nazione indiana”), ci dice che è stata scritta negli anni Settanta. Per inciso, fa sperare nel genere umano l’amicizia stretta tra due scrittori capaci di autentici capolavori: l’uno in prosa (“La lucina” ne è l’esempio più recente) e l’altro in poesia. E qui ci si riferisce proprio a “Macello”, opera perfetta, unitaria e coerente nel tema e nello stile. Ci si domanda infatti chi altri, almeno tra i poeti italiani delle ultime generazioni, sarebbe capace di un esito simile trattando una materia così letteralmente cruda come ciò che accade in un mattatoio, senza alcun trucco o trasfigurazione. Anzi, soprattutto descrivendo, e restituendo a un microcosmo marginale e sconosciuto a molti la centralità simbolica della vita stessa. Qui la condizione dell’esilio (da sé, dal mondo) viene illuminata dalla forza inedita di una poesia arcaica ed elaborata, materiale e filosofica, chiusa nella sua durezza eppure aperta a traslati allegorici di grande efficacia. Una raccolta straordinaria, chiusa da una poesia straordinaria (p. 88):
Su un oceano colorato malamente
galleggiava una piccola isola
le onde spargevano le origini
i coralli cicalavano al tramonto
e i pesci si rigeneravano alla fonte.
Era una goccia di sperma
cadutami nella vasca del sangue
in una mattina
di forte macellazione.
Dopo la parentesi di “Rosso epistassi” (Effigie 2008), Ferrari torna nel 2013 ad Einaudi con “La morte moglie”. Il titolo scelto per la raccolta è l’esplicita indicazione di contenuto della seconda delle due parti di cui si compone, mentre con la prima (“Le bestie imperfette”) l’autore ci offre la sorpresa di poesie appartenenti al periodo di “Macello”, a quest’ultimo affini anche per tema. Ed è proprio qui che di nuovo si palesa quella voce “dissonante e unica” (A. Moresco, in quarta di copertina), mossa dai margini e così rara ovunque, esito massimo della sua poesia.
Con decine di colpi
abbiamo frantumato l’ultima testa
si rispetta l’orario non la misura
come dentro la terra
il gelo chiude la questione. (p. 22)
A p. 30 si descrive in diretta l’uccisione di un animale, a p. 32 si racconta del guarire degli animali per poi essere comunque ammazzati. E si procede così, quasi senza tirare il fiato, fino all’ultimo verso riferito a una farfalla: “… e lei via / verso altri modi di morire”. Un aggancio, forse, all’avvio della raccolta successiva: “Fai segni / oscillando le dita a graffio”, dall’animale all’umano senza differenza. Anche in questa seconda sezione, infatti, “si tratta di staccare ogni parola / dalla carne” (p. 54).
Se un’evoluzione nel tempo c’è stata, essa riguarda un uso più sofisticato del linguaggio, che solo raramente apre squarci nella nuda realtà, un tempo detti con la rozzezza unica delle parole più precise. Oppure con il sarcasmo, per tenere a bada ciò che in natura si dava come insopportabile.
C’è anche il mistero di una quartina ripetuta (che torna dopo trent’anni, da p. 3 a p. 58: “Gli occhi precipitano / anzi si perdono in alto / dove la voglia di vivere / copre il soffitto di ali”), forse a testimoniare, appunto, che tra dolore animale e umano non c’è differenza. Torna anche il vento, che “scompiglia i peli” (a p. 10 delle bestie, a p. 74 di una testa umana), personificato come un “animale”, che “guaisce e ringhia”. E poi lei, la moglie (p.64), che si abbraccia alla morte fin dal titolo, in un tutto di nulla fino al punto finale:
Sei tu la materia che mi converte
che sanguina docile negli occhi
si è spenta l’ombra
il corpo invece piroetta in aria
e come avessero una testa sola inseguono
due o tre fiori domenicali
eppure la paura non è niente di intero
la pace non contiene nulla.
